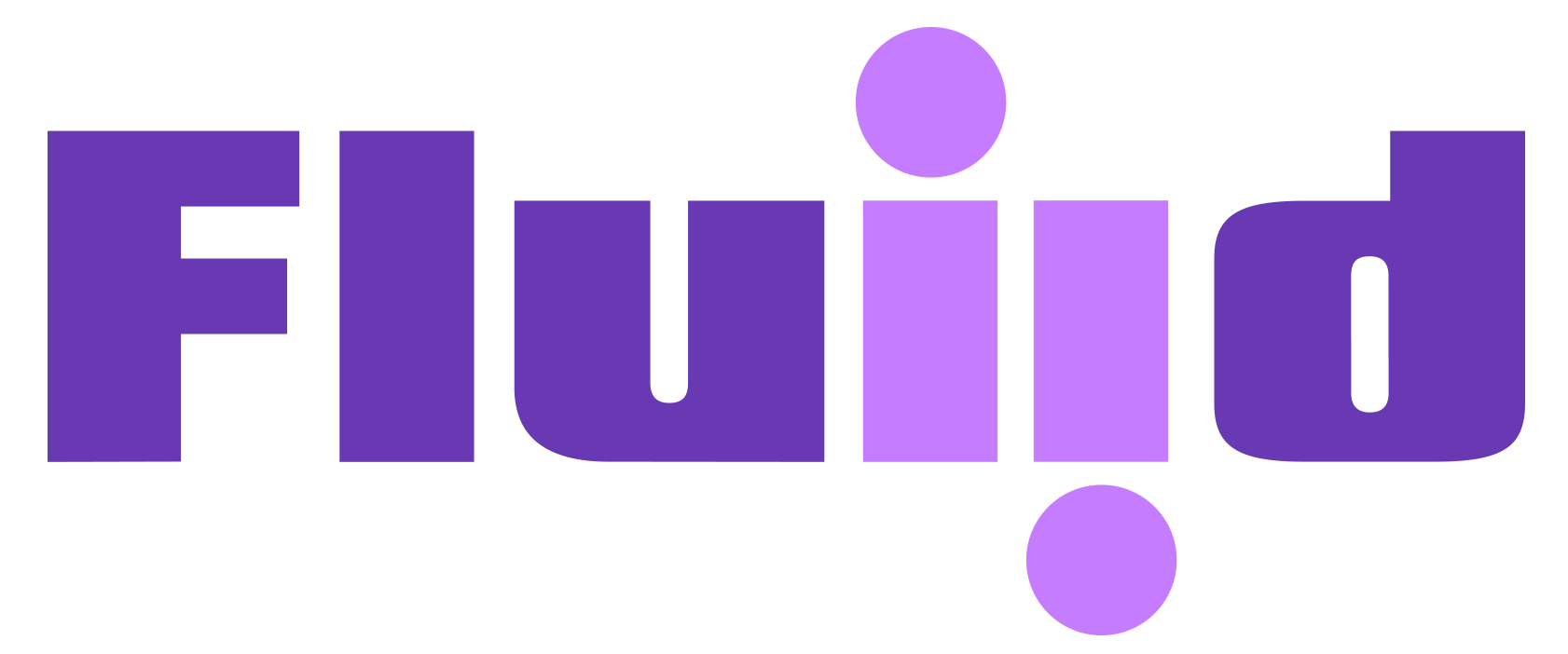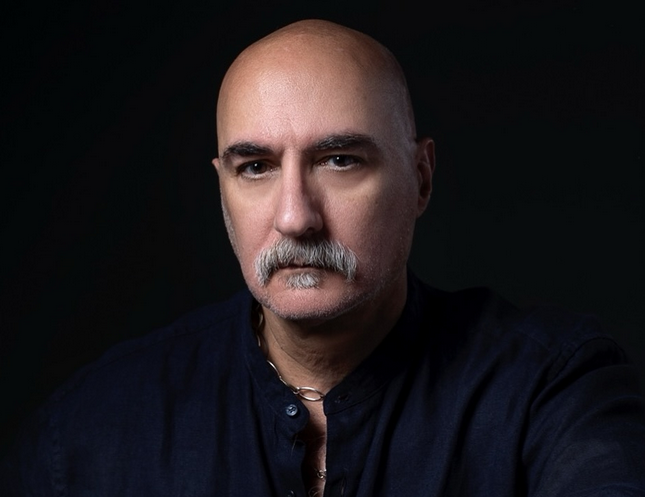Morto a 27 anni in una struttura psichiatrica, il giovane tiktoker transgender aveva lanciato appelli quotidiani tra dolore, solitudine e ricerca di ascolto. Ora i social fanno i conti con l’indifferenza.
“Sto aspettando di andare in un posto… probabilmente sarà la fine dei miei giorni”. Era uno degli ultimi video pubblicati da Thiago Elar, 27 anni, tiktoker transgender ricoverato da oltre un anno e mezzo in una clinica psichiatrica. La notizia della sua morte è arrivata lunedì 21 luglio, confermata da un necrologio apparso online. Il funerale si svolgerà a Osio Sotto, in provincia di Bergamo.
Chi era Thiago? Un ragazzo, un creatore di contenuti, ma soprattutto una voce spezzata che per mesi ha cercato disperatamente un contatto umano, un riconoscimento, un sostegno. Attraverso TikTok – dove era seguito da oltre 145mila persone – aveva trasformato la sua permanenza in psichiatria in un racconto quotidiano. Video spesso simili, ossessivi, ripetuti, ma autentici nella loro urgenza: la richiesta di essere visto, riconosciuto, creduto.
Una vita vissuta in diretta, tra rifiuto e speranza
Thiago si era raccontato a viso scoperto, parlando del proprio passato segnato da traumi, disturbi alimentari, conflitti familiari. Più volte aveva denunciato un rapporto spezzato con la madre, fatto di dolore e incomprensioni. Alcune sue frasi, rivolte direttamente a lei, tornavano ciclicamente nei video: appelli semplici e struggenti, “Portami via”, “Non voglio morire qui”. Alcuni dei contenuti erano stati letti da una parte del pubblico come richieste strumentali, generando critiche e anche accuse di manipolazione. Ma al di là delle polemiche, rimane il dato crudo: un ragazzo giovane, fragile, rinchiuso in una struttura sanitaria, è morto dopo mesi di denunce pubbliche ignorate o ridicolizzate.
L’ombra del dead name e la battaglia per l’identità
Nonostante la sua identità di genere fosse chiara e pubblicamente espressa, perfino nel necrologio è stato utilizzato il nome assegnato alla nascita. Un dettaglio solo in apparenza formale, che rivela la fatica di ottenere riconoscimento sociale e familiare per molte persone transgender. Thiago aveva chiesto esplicitamente di essere chiamato col suo nome scelto. Anche questo, troppo spesso, gli è stato negato. La sua morte chiude una narrazione che, giorno dopo giorno, aveva mostrato senza filtri la realtà della marginalizzazione psicologica, affettiva e sociale che molte persone queer e neurodivergenti vivono in Italia. E costringe a porsi una domanda dura: chi ha ascoltato veramente Thiago?
Le responsabilità di una società che silenzia il dolore
Non è possibile dire con certezza se Thiago avrebbe potuto essere salvato. Ma è legittimo interrogarsi su quanto la sua sofferenza sia stata davvero presa in carico dalle istituzioni, dalla famiglia, dalla società. In un tempo dominato dalla comunicazione social, l’esposizione del dolore non basta a generare empatia reale. E il rischio, sempre più concreto, è quello di un dolore che diventa contenuto, ma non responsabilità.
La vicenda di Thiago Elar non può essere archiviata come semplice cronaca. Deve essere compresa come un grido collettivo, un promemoria per la sanità mentale pubblica, per il sistema familiare, per il mondo educativo e culturale. Perché non si può morire a 27 anni dopo aver chiesto aiuto ogni giorno, in diretta, davanti a migliaia di spettatori.